(di Reno Brandoni e Andrea Carpi / foto di Daniele Barraco) – Il primo libro importante che ho letto nella mia vita è stata la biografia di Bob Dylan di Anthony Scaduto. Il tutto è successo per caso, frutto di un semplice gioco del destino. Ero un quindicenne, frequentavo le librerie più per curiosità che per voglia di leggere. Ascoltavo molta musica ed ero smanioso, sempre alla ricerca di riferimenti emotivi. Mi parlarono dell’uscita di Blood on the Tracks di Bob Dylan come di un grande capolavoro, acquistai il disco per non deludere l’artefice del suggerimento. La mia ricerca musicale viaggiava su altri generi, ma quando tra gli scaffali del negozio vidi la faccia di Dylan su quella copertina rosso fuoco, fui preso dall’ansia del possesso; curioso di capirne un po’ di più sul personaggio, comprai il libro. Certo, la storia funzionerebbe meglio e sarebbe più in tema se vi raccontassi di un ‘furto’ in libreria; ma così non fu, usai i miei risparmi per portare a casa quel volume. Rimase impolverato per circa un anno insieme ai libri di scuola, sullo scaffale della mia camera, poi una sera inspiegabilmente iniziai a sfogliarlo e a leggere qualche pagina. Da allora non smisi più. Tutto il mio percorso letterario fu guidato da quel libro, dai poeti della Beat Generation a Steinbeck fino ad arrivare alla poesia di Dylan Thomas.
Dylan così è diventato la guida di tutta una vita. E sempre ho cercato di immaginare come sarebbe stato bello nascere in America per poter apprezzare i testi delle sue canzoni immediatamente, senza dover ricorrere alle traduzioni, che purtroppo fanno perdere il bello della liricità accoppiata alla musica. Questo sogno è rimasto nel cassetto fino a quando…
Francesco De Gregori è stata ed è un’altra grande passione, talmente coinvolgente da farmi recensire i suoi dischi con grande fatica, in quanto vittima di un giudizio mai imparziale.
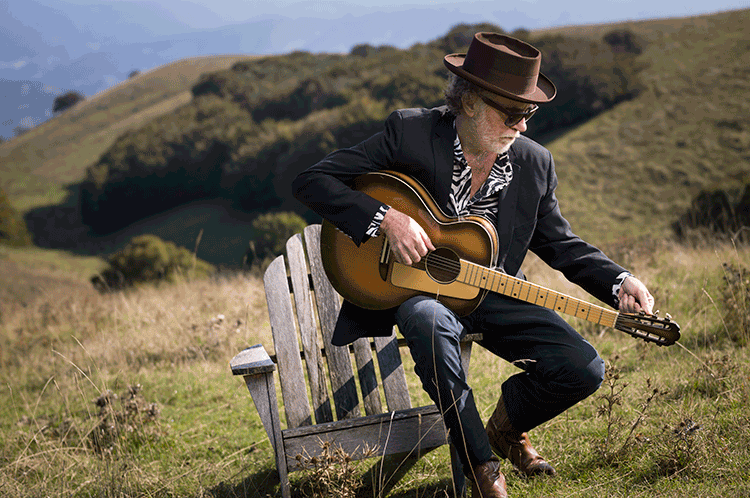
Lui cantava alla Dylan, scriveva alla Dylan, ma era De Gregori: la sua caratteristica emergeva preponderante e prepotente, come a dire ti ricordo lui ma non sono lui. La storia dei due si è sempre mossa su binari paralleli, mai convergenti, e così li ho tenuti sempre nettamente separati nei miei gusti e nei miei ricordi. Solo una volta, quando un giorno De Gregori dichiarò di aver preso ispirazione da “Winterlude” di Dylan per la sua “Buonanotte fiorellino”, ho riascoltato migliaia di volte quella canzone di Rimmel cercando di percepire nella sua musica quel verbo dylaniano che mi mancava per completare il mio sogno.
 Poi è arrivato Amore e Furto e tutto è cambiato. Ho riconosciuto Dylan nelle sue parole, nella sua lirica, ho capito l’impatto emotivo dei suoi testi, la poesia delle sue rime. Ma non era Dylan, era De Gregori che me le raccontava. Non era un disco di Bob Dylan, ma un nuovo disco di Francesco De Gregori, che per quanto dedicato o forse ‘rubato’ a Dylan rispecchiava totalmente il carattere di entrambi. Rubo una citazione di Andrea Carpi, che più azzeccata non poteva essere: è questo il caso in cui «uno più uno uguale tre». Ecco, nasce proprio una nuova entità che non è un ibrido ma frutto di una fusione, generazione di un nuovo indiscusso grande passo nella nostra discografia.
Poi è arrivato Amore e Furto e tutto è cambiato. Ho riconosciuto Dylan nelle sue parole, nella sua lirica, ho capito l’impatto emotivo dei suoi testi, la poesia delle sue rime. Ma non era Dylan, era De Gregori che me le raccontava. Non era un disco di Bob Dylan, ma un nuovo disco di Francesco De Gregori, che per quanto dedicato o forse ‘rubato’ a Dylan rispecchiava totalmente il carattere di entrambi. Rubo una citazione di Andrea Carpi, che più azzeccata non poteva essere: è questo il caso in cui «uno più uno uguale tre». Ecco, nasce proprio una nuova entità che non è un ibrido ma frutto di una fusione, generazione di un nuovo indiscusso grande passo nella nostra discografia.
La curiosità di chiedere a De Gregori i retroscena dell’operazione era troppo grande, per non cercare ogni mezzo per ottenere un’intervista. Così, dopo qualche scambio di email con gli amici di Parole & Dintorni, sua agenzia stampa, arriva la conferma dell’incontro: sarà un giovedì del mese di ottobre, a Roma, insieme ad Andrea, col quale da anni condivido la medesima passione per il cantautore. E questo è il frutto della lunga chiacchierata, iniziata con un semplice arpeggio di Francesco e conclusa con l’ascolto di un po’ di musica di Bob. Abbiamo parlato di tutto, anche di musica e di chitarre, ma non voglio togliervi la sorpresa della lettura; mi piace solo sottolineare l’ultima frase di Francesco prima dei saluti: «Chiaramente lo avete capito, è stato un piacere parlare con voi». (r.b.)
A.C.: Si parla spesso dei due periodi della musica di De André: il primo più legato al movimento dei chansonnier francesi; il secondo ispirato ai singer-songwriter americani e caratterizzato dalla collaborazione con Massimo Bubola. Ma in mezzo ci sei stato tu, con la partecipazione nel 1974-75 a Canzoni e Volume 8 di De André e alla sua prima interpretazione di “Via della povertà”: come hai vissuto questa transizione dalla cultura dei chansonnier a quella dylaniana?
Che fosse musica classica, che fosse jazz, che fossero cantautori giovani come potevo essere io, Fabrizio tendeva ad assorbire tutto, perché era un uomo curioso. E in questo forse mi ricorda un po’ Dylan, perché di Dylan si dice che tuttora, se va a casa di qualcuno e gli piacciono dei dischi, se li ‘ruba’… Non so se sia vero, ma c’è un episodio narrato nelle sue biografie di quand’era ragazzino e si faceva ospitare sui divani, in quella vita randagia del Village: magari capitava a casa dell’intellettuale radicale americano che aveva un sacco di dischi e un sacco di libri, e lui in tre giorni assorbiva tutto, o addirittura se ne appropriava proprio fisicamente; perlomeno si racconta che in un caso si fregò un po di dischi… E De Andrè era questo tipo di musicista: tutto quello che gli capitava di ascoltare lasciava le sue tracce. Un giorno, poi, arrivò al Folkstudio che suonava mio fratello Luigi…

A.C.: E tu suonasti “Dolce signora che bruci” come ospite…
Sì, feci “Dolce signora che bruci”, quindi un fingerpicking credo rudimentale, che sicuramente lui notò. In seguito, continuando a venire al Folkstudio, lui sentì anche “Desolation Row“, che io avevo tradotto in italiano. E questa cosa lo impressionò tantissimo, perché era diversa da tutte le canzoni che aveva scritto lui; e assolutamente diversa da tutte le canzoni dei cantautori storici italiani come Tenco, Paoli, Bindi, insomma quello che era il suo mondo di rappresentanza. In effetti, io gli aprii una finestra su un mondo culturale e musicale che ignorava e al quale si volle pian piano convertire, sia come scrittura, sia come modo di cantare. Quindi io assistetti, testimone innocente, a una sua trasformazione. Perché non è che lo spinsi io a far questo, però attraverso di me lui venne a conoscenza della musica angloamericana e soprattutto di Dylan, dal momento che io ero sotto un forte influsso dylaniano allora, forse più di adesso. E lui si abbandonò volentieri su questa strada.
A.C.: Però tu avevi avuto anche influssi deandreiani, eri anche in quella linea…
Certo, quindi ero forse proprio per questo la persona adatta a fare da mediatore, perché non ero uno che arrivava con un bagaglio musicale del tutto estraneo al suo e a cui non interessava quello che faceva, Brassens, i francesi, “La canzone di Marinella”… No, io ero uno che comunque condivideva quel mondo e ne era stato affascinato; e tutt’ora rimango affascinato anche da quel mondo là. Però, contemporaneamente, gli ho aperto una finestra e lui ci ha subito guardato fuori; poi gli ho aperto una porta e lui ci è subito entrato dentro.
A.C.: Personalmente come hai avvertito questo momento di passaggio?
Sì, forse me ne rendevo conto, e mi sembrava del tutto naturale che avvenisse. Poi, letto dopo quarant’anni, capisci che in effetti in quel momento era stato un passaggio forte. Ma allora si trattava semplicemente di un mio collega, di un mio mito musicale, che si era imbattuto in altre suggestioni culturali, tecniche anche, e che ne era rimasto affascinato. Era del tutto normale che avvenisse questo. In definitiva pure io, attraverso il Folkstudio, ero passato attraverso l’influenza delle canzoni popolari italiane, che non conoscevo; e dopo aver ascoltato tante volte Otello Profazio, Giovanna Marini, Caterina Bueno, il Duo di Piadena, Matteo Salvatore, avevo importato tutte queste cose nel mio modo di fare musica. In effetti, a rileggere adesso la storia musicale di De André, in quegli anni lì lui cambiò proprio registro al punto tale che, come accade sempre quando entri in un territorio nuovo, si sentiva un po’ sperduto. E mi ricordo che quando registrava Volume 8 io stavo lì per lui, perché voleva che fossi in sala con lui. Su certe cose si smarriva, nel canto non si piaceva. Ed io lo tranquilizzavo: «Fabrizio, l’hai cantata benissimo questa canzone!» C’era pure il produttore Roberto Danè che diceva: «Ma che sei matto? L’hai cantata bene.» E lui era disperato: «Sentite che non canto bene?» In certi momenti sembrava brancolare.
A.C.: In quel disco hai suonato la chitarra in “Le storie di ieri”…
Sì, ho suonato la chitarra in “Le storie di Ieri” e l’avevo suonata anche in “Via della povertà” su Canzoni. In “Via della povertà” avevo suonato indegnamente anche l’armonica, errore che non farei mai più…
A.C.: Questa cosa dello smarrimento di De André a me fa pensare che poteva starci anche l’uso del fingerpicking; perché il fingerpicking – noi forse non ce ne rendevamo conto allora – ma porta dentro di sé quel ritmo incrociato ‘nero’, afroamericano…
Infatti credo che poi lui si imparò anche a farlo, perché era un uomo metodico e disciplinato. Comunque è vero, il fingerpicking stabilisce la linea di confine fra la linea valzeristica in battere e un mondo che si apre, anche a livello di composizione musicale. Lui del resto era ansioso di novità, tant’è che anni dopo incise anche un disco con la PFM: questo testimonia la sua grande apertura verso mondi sonori che non lo riguardavano in partenza, ma dei quali lui si voleva appropriare; come poi alla fine ogni artista, non solo è legittimato a fare, ma anzi deve fare.
A.C. Più specificatamente, cosa ha portato Dylan per te nella nostra cultura sul piano musicale, testuale e vocale?
Guarda, all’inizio è stato soprattutto il suono complessivo. Non voglio dirti le parole, che pure sono importanti, perché Dylan ha sconvolto il modo di fare i testi delle canzoni, ma era soprattutto il suono. Era un suono anche misterioso, perché non capivo com’era fatto, non capivo com’era confezionato: ero solo un ascoltatore a quei tempi, tutt’al più suonavo la chitarra in camera mia, però quando sentii soprattutto Highway 61 e Blonde on Blonde, quindi il suo passaggio ‘elettrico’, veniva fuori un suono che non avevo mai sentito da nessuna parte. Non era il suono dei Beatles, che pure mi piacevano, non era il suono dei Rolling Stones. E mi dissi: «Ma questo da dove viene?» Quando parlo di suono parlo di arrangiamenti, parlo di suono di chitarre, parlo di sistemi di registrazione e parlo soprattutto della voce. Tu mi parlavi anche della voce di Dylan, cosa ha rappresentato per me, quanto mi ha influenzato? Ma evidentemente moltissimo. Faceva parte di quel suono per me misterioso, e attraverso il suono di quei dischi capivo che c’era un mondo artistico di Dylan, un universo espressivo che mi faceva ‘sballare’. Credo che questo sia successo a tanti altri artisti; leggo delle vecchie interviste di Springsteen, in cui racconta di quando ascoltò per la prima volta “Like a Rolling Stone” partire con quel colpo di rullante e dice: “Quel colpo di rullante ha cambiato la storia del rock!» Poi scrivono che De Gregori è uno che ha Dylan lì: sì, ma io come tanti altri…

A.C.: Pure John Lennon…
Sì, certo, ma John Lennon già era scafato. Io ero un ragazzino di quindici anni, pigliavo appena in mano la chitarra, e mi arrivano fra capo e collo due dischi come Highway 61 e Blonde on Blonde e poi tutto il resto a seguire: come fai a non tenerne conto? Era difficile per un musicista che nasceva in quegli anni non tenerne conto.
R.B.: Eppure la sensazione che si aveva ascoltandoti all’inizio era che tu fossi legato di più al primo periodo di Dylan, quello folk.
Il Bob Dylan folkeggiante di “Blowin’ in the Wind” in Freewheelin’, anche quello mi ha dato una grossa botta. La canzone in questione l’avevo già sentita prima nella versione di Peter, Paul and Mary e mi era piaciuta molto, ma senza che mi buttassi dalla finestra. In seguito, quando mio fratello mi portò il 45 giri con l’interpretazione di Dylan, forse dopo un anno o più, rimasi impressionato da quanto fosse apparentemente scarna rispetto all’altra versione, e sentivo che lì la chitarra aveva un gran suono; poi mi direte voi come la suona lui questa chitarra, in accordatura aperta?
R.B.: No, in accordatura standard…
A.C.: Col capotasto al VII tasto in posizione di Sol; ma in altri pezzi di Freewheelin’ suona in accordatura aperta…
Ecco, vedete, c’è un segreto.
R.B.: Restando a quel periodo di Dylan, io ho accompagnato Dave Van Ronk in tour per tanto tempo…
E lui ce l’aveva ancora con Dylan? Nel primo album Dylan gli ha ‘fregato’ tutti gli arrangiamenti. Ancora un furto! Come dicevamo all’inizio, Dylan è come De André, una spugna. E Picasso diceva sempre: «I mediocri imitano, i geni copiano». Non capisco bene la frase, che cavolo volesse dire, ma suona molto bene! A orecchio, potrei vederla così: se mi dicono che imito Dylan, per me è un offesa; se mi dicono che lo copio, non mi sembra un’offesa: la parola imitazione mi dà l’idea del mobile in stile; la parola copiare riflette l’artista che si rifà a qualcosa che lo ha preceduto e che assume come modello. E, onestamente, lo rifà immettendoci anche involontariamente la sua nervatura, la sua cultura, il suo talento. Quindi non sarà mai una copia, è impossibile fare una copia. Questo spiega tante cose di Dylan che frega gli arrangiamenti a Van Ronk. Se Van Ronk avesse fatto lui quel disco, non sarebbe successo niente nella musica nel mondo. Lo fa Dylan e diventa Dylan: è il primo tassello di un percorso artistico che poi arriva dove arriva.
Comunque, per rispondere ancora a Reno, io rimango molto impressionato da “Blowin’ in the Wind”. Però ancora di più rimango impressionato dopo qualche anno, quando vedo che lo stesso personaggio che ha fatto “Blowin’ in the Wind” in quel modo, che già ‘spaccava’ come dicono i giovani d’oggi, mi fa una cosa completamente diversa rimanendo se stesso – o non rimanendo se stesso, questo è un mistero di Dylan che non verrà mai chiarito, quanto sia se stesso e quanto tradisca se stesso – e mi scarica addosso una mole di suono che mi lascia di stucco a pensare: «Ecco, questa è la musica che vorrei fare!» Come tutti i ragazzi che sentono un disco e dicono: «Questa è la musica che vorrei fare».

R.B.: Quindi sei stato affascinato dal suo ‘cambiamento’?
Sì, sono stato affascinato dal cambiamento. Quello è stato secondo me il cambiamento più radicale, più felice di Dylan, il più eversivo. Poi ne ha fatti tanti altri, molto importanti per lui e anche per il suo pubblico, fino all’ultimo disco dove fa Frank Sinatra e lo fa da dio. Però diciamo che – un po’ data anche la mia età e il mio consumato mestiere di musicista, dopo quarant’anni – questo mi ha fatto meno impressione. Ma quel tradimento lì fu di una bellezza, fu un regalo per il mondo!
R.B.: Tra i vari cambiamenti di Bob Dylan, per un periodo ha seguito il ‘filone’ religioso. È qualcosa che ti ha stupito?
Sì, ma senza particolare enfasi. L’ho presa come una scelta personale di Dylan e l’ho accettata. Ci sono belle canzoni che lui ha scritto in quel contesto, altre meno belle; anche lui ha scritto canzoni belle o meno belle, come tutti noi. Non mi ha sconvolto, insomma, non ha avuto niente a che vedere con il cambiamento da “Blowin’ in the Wind” a Highway 61, che è stato un cambiamento artistico radicale. Del resto Dylan dal punto di vista spirituale è sempre stato un uomo che riecheggia una fortissima spiritualità, basta ascoltare una canzone più recente come “Not Dark Yet” [da Time Out of Mind, 1997]. Ma quello lì è stato un periodo, una sua scelta personale. Quando poi ha inciso Infidels, lo ha chiamato Infidels come a dire: è finito questo periodo, adesso torno, abbandono quella che può essere stata una certa dogmaticità, un certo innamoramento per questa religione strana. Ma lui è un uomo imprevedibile, a un certo punto si è messo a fare il pittore, adesso per esempio fabbrica cancelli, è un uomo sorprendente. Dopo, prima di andare via, vi faccio sentire una cosa di Dylan, così mi dite quanto è imprevedibile…
A.C.: Più specificamente, che influenza hanno avuto su di te la chitarra di Dylan e i chitarristi che hanno suonato con lui?
Appunto ti dico, “Blowin in the Wind” fatta voce e chitarra sembrava tanto semplice apparentemente, poi provavi a rifarla e c’era sempre qualche cosa che ti scappava. Il modo di suonare la chitarra di Dylan non era facile da capire, un po’ per come l’accordava su certi pezzi, un po’ per come metteva il capotasto, un po’ per il tipo di suono; ritorno sempre a questa parola, perché di suono stiamo parlando, che sia la chitarra, la voce o quello che ti pare. E Dylan all’inizio le chitarre le faceva sentire molto fuori, anche le acustiche. Poi un’altra chitarra importante è stata quella di Charlie McCoy su “Desolation Row”, quella che fa quegli arpeggi, quegli ‘svisi’; definirli spagnoleggianti è riduttivo, fa qualcosa che non appartiene a nessuno stile preciso, appartiene allo stile di quella canzone, appartiene alle parole di quella canzone. Più recentemente, in “Sweetheart Like You” del 1983, c’è quell’assolo finale di Mick Taylor che è straordinario; e io ho chiesto a Paolo Giovenchi di rifarmelo uguale: lui è così bravo, che è riuscito a farlo diverso che sembra uguale.
Insomma, Dylan un po’ lo sentivo mio fratello, nel senso che suonava lo stesso strumento che cercavo di suonare io, e questo era come un ‘gancio’ nel mio voler essere come lui, nel voler fare la musica che mi piaceva e che lui già aveva fatto: c’era la chitarra di mezzo che era un ponte. Se Dylan fosse stato un pianista, fosse stato Elton John per dire, questa cosa sarebbe mancata. Il fatto che Dylan si mostrasse con la chitarra, che era lo lo stesso strumento che avevo in mano io, lo stesso che aveva in mano Caterina Bueno, era qualcosa che affratellava, che accomunava. Allora suonavamo tutti la chitarra. Vabbe’, tranne Antonello, che aveva ’sta schiavitù del pianoforte…
A.C.: Qui ti chiederei di raccontare del fingerpicking, di come lo hai imparato, che poi è uno degli elementi base dell’avvicinamento al mondo musicale angloamericano.
Io all’inizio sentivo che qualcosa di diverso c’era in quel modo di suonare la chitarra, soprattutto nei dischi che sentiva Luigi a casa; perché era lui che ha portato quella musica dentro casa nostra. Così mi ero inventato quel fingerpicking che vi ho fatto sentire prima – non so se riuscirete a descriverlo con le parole – e che era una fake fingerpicking, ma dava però quell’idea del levare…
A.C.: Quello che arrivava subito era una sorta di ‘saltello’…
Esatto, questo saltello, questo ‘singhiozzo’; perché come lo facevo io era un singhiozzo. Ed era difficilissimo farlo, ma lo insegnai ugualmente a De André, nel modo sbagliato. Poi, grazie a dio, una mia amica che poi sarebbe diventata mia moglie, la quale era andata invece a lezione da Janet Smith ed era precisissima, mi prese da una parte e mi disse: «No, guarda che lo devi fare così». Mi ricordo che forse è stata una delle poche volte che ho preso lezioni di chitarra in vita mia, se non l’unica, e la presi giustamente da mia moglie. Per quattro-cinque giorni mi allenai, credo su “Don’t Think Twice, It’s All Right”…
A.C.: Che infatti era uno dei pezzi che Janet Smith ci insegnava fin dall’inizio…
E un altro era “Freight Train”… Insomma, attingendo al massimo di quelle che sono le mie capacità di essere disciplinato, alla fine misi su un fingerpicking decente, che riconsegnai poi a Fabrizio; gli dissi: «Guarda che ti avevo detto una cazzata, in realtà si fa così»; e credo che se lo sia imparato anche lui. Però io non sono mai diventato un bravo suonatore di fingerpicking. Adesso, dal vivo, ci sono dei pezzi che vorrei fare ma non li rischio, anche perché all’interno di una band è difficile che si crei uno spazio per il fingerpicking. Oltretutto la chitarra andrebbe amplificata col microfono per farla suonare bene, perché il suono in diretta nell’impianto – per quanto tu possa curarlo molto – non rende giustizia a un arpeggio; e il fingerpicking alla fine è un arpeggio.
R.B.: Questa è una cosa che sottolineerei, perché oggi tutti i ragazzi vogliono che la chitarra sia amplificata.
Pure io, perché è comodo se devi suonare con una band…
R.B.: Però se fai il chitarrista solista…
Se suoni solo la chitarra, tu dovresti pretendere di avere un microfono.
R.B.: Il suono ‘vero’ è quello.
Infatti, in molte delle foto di Dylan che vedete, lui tiene la chitarra vicino alla faccia. La tiene così perché ha il microfono per cantare, e quando smette di cantare – per avere dinamica nell’esecuzione – avvicina la chitarra al microfono per alzarne il volume in quel punto.

A.C.: Questa è una cosa che deriva anche dalla tradizione americana: nel bluegrass, quando suonavano con un solo microfono, i diversi membri della band si avvicinavano o si allontanavano per gestire la dinamica.
E lui alzava la chitarra per avere una dinamica naturale, cosa che se hai la chitarra amplificata in diretta, chiaramente non puoi fare.
A.C.: Comunque, anche se il fingerpicking va bene per suonare da soli e può essere usato più difficilmente con la band, però ha contribuito sicuramente a introdurre nel modo di suonare un’impronta ritmica nuova.
Che è nuova e può sostituire anche una band, può sostituire anche un’orchestra, perché ha dentro di sé un elemento percussivo, un elemento ritmico molto forte.
A.C.: Arriviamo al disco e alle tue traduzioni: come hai ottenuto questo equilibrio sorprendente tra fedeltà al testo originale, rispetto della metrica e delle rime, ricerca della cantabilità in italiano e contributi originali?
Avrei voluto essere anche più fedele, ma non sempre è stato possibile. Nelle traduzioni che avevo fatto in passato per divertimento, alcune poi pubblicate e riprese anche in Amore e Furto, avevo avuto un approccio più disinvolto e giovanile, più autonomo e anche più autoreferenziale. Ma in questo disco, dopo tanti anni di esperienza professionale nel mondo della musica, ho trovato giusto adottare un atteggiamento più attento e fedele. E per esempio “Via della povertà” e “Una serie di sogni“ – rifacimento di “Series of Dreams”, che era stato interpretato da Mimmo Locasciulli nel suo album di cover Il futuro del 1998 – le ho molto rimaneggiate per aderire al nuovo spirito che mi sono dato. Una ricerca di fedeltà che non è stato facile rispettare. Intanto bisognava capire bene il senso letterale delle cose dette da Dylan, non sempre facilmente decifrabili. Da questo punto di vista mi è stato di grande aiuto il libro di traduzioni Bob Dylan. Lyrics 1962-2001, curato da Alessandro Carrera. Poi, al di là del senso letterale, bisognava capire in certe occasioni cosa veramente volesse intendere Dylan, e a cosa facesse riferimento. E nei passaggi molto ‘localizzati’ e ‘contestualizzati’, bisognava adattare certi dettagli in modo che potessero essere apprezzati anche qui da noi. Infine, la cosa forse più importante, bisognava rendere il tutto scorrevole e cantabile in italiano, in modo che non sembrasse appunto una ‘traduzione’ di qualcosa.
A.C.: I tuoi rimaneggiamenti nel tempo di “Via della povertà” o “Una serie di sogni” richiamano una domanda: il tuo approccio alle traduzioni è stato più istintivo/naturale, o legato a un lavoro paziente e metodico?
Bella domanda. All’inizio direi istintivo/naturale, nel senso che la scelta dei pezzi non è avvenuta a tavolino: andavo a cercare spontaneamente tra le canzoni che mi piacevano, provando a vedere se trovavo degli agganci di titoli o di versi che rendevano subito nella traduzione. Una volta trovata questa prima scintilla, però partiva il lavoro paziente e metodico.
A.C.: Immagino che sia stato necessario chiedere delle autorizzazioni per realizzare le traduzioni.
Sì, abbiamo dovuto mandare alle edizioni originali le traduzioni in inglese, che ho fatto fare a una traduttrice, delle traduzioni in italiano fatte da me. Non so se Dylan stesso se le sia lette, ma comunque ci sono state approvate. La prima esperienza in questo senso l’avevo avuta con Locasciulli, in occasione del suo album citato prima, Il futuro, che conteneva anche una mia traduzione di “The Future” di Leonard Cohen, oltre ad altre traduzioni varie di Mimmo. Tutto filò liscio, tranne che per “Powderfinger” di Neil Young, che fece rifare la traduzione più volte, fino a che si cercò di convincerlo che era una buona occasione per far arrivare la comprensione della sua canzone al pubblico italiano. E lui finalmente accettò.
A.C.: L’immediatezza del suono della parola cantata che hai ottenuto in queste traduzioni, riflette anche l’immediatezza del suono dei testi nelle tue canzoni. Quando ascolto una canzone, di solito vengo attratto più facilmente dalla musica, mentre nell’immediato riesco a seguire più difficilmente il testo. Nel tuo caso invece riesco a seguire subito il testo insieme alla musica.
Questo è un bel complimento, grazie. Be’, essendo nato sotto la stella di De André, alla fine è chiaro che per me la canzone vuol dire anche parole, non dico soprattutto, ma anche le parole. Ricordo che quando ero proprio piccolo piccolo, mia madre sentiva l’opera alla radio, come tutte le ‘brave ragazze’ della sua generazione. Io la sentivo con lei e mi piaceva tutto questo suono, tutte queste voci, però mi lamentavo che non capivo le parole. Quindi questo mio amore per capire il senso, per capire il testo c’è sempre stato. E una volta diventato un cantante, probabilmente cerco di fare in modo che le mie parole si capiscano, sia nel missaggio, sia nella scansione mentre canto; nel missaggio però bisogna stare attenti a non mettere la voce troppo fuori, perché è una cosa che odio. E la musica è importante, è forse la cosa più importante, il suono è importante, e torniamo alla parola ‘suono’, ma sempre che la musica non renda le parole incomprensibili: non solo devono rimanere comprensibili, ma devono avere peso, devono avere il suono.
R.B.: Invece di ricordarti la melodia, devi ricordarti la sequenza di parole.
È l’importanza sonora: il testo può anche essere una stronzata, però le parole devono avere un’importanza.
A.C.: In un’intervista recente dicevi di Dylan che le sue parole cantate sono come ‘come sassi’. Senza fare paragoni, però De André è effettivamente uno che ti fa capire bene i testi, ma usa un altro sistema: lui articola molto bene sfruttando la sua voce stentorea, però in un certo senso è meno musicale…
È un altro tipo di musicalità…
A.C.: Mentre in te è proprio la musicalità che colpisce, e la canzone arriva così, direttamente.
Però, così come io ho avuto l’imprinting di De André, lui ha avuto l’imprinting di Brassens, dei francesi, di Brel, che coltivavano forse il culto della parola in modo diverso.
R.B.: In te io trovo la ‘frase’, mentre in De André c’è il ‘concetto’; in te c’è il ‘periodo’ che già ha la sua completezza, per questo forse necessita di meno memoria…
Per esempio io non uso il ‘gobbo’ quando canto, mentre tutti ormai hanno davanti il gobbo elettronico. Tra i miei colleghi, soprattutto quelli dai cinquant’anni in giù, non ne trovi uno che non lo usi: piuttosto fanno a meno dei monitor, ma il gobbo ce lo devono avere. Io invece il testo piuttosto me lo dimentico e me lo reinvento lì per lì, mi capita anche questo, oppure salto una strofa, ma so esattamente dove va a parare la canzone quando canto, so di cosa sto parlando.
R.B.: Tu hai sempre detto di non voler essere considerato un poeta, ma ricordo che Dylan dichiarò in una vecchia intervista che la forza delle canzoni è nelle liriche; e che lui potrebbe cantare le sue canzoni su una qualsiasi delle sue musiche, senza che perdano valore o senso.
Sul discorso della poesia io reagisco sempre con un po’ di difficoltà, perché la gente che me ne parla non ha spesso cognizione di cosa sia la poesia. Ci sono persone che non hanno letto nulla della poesia contemporanea italiana degli ultimi cinquant’anni, non sanno chi è Maurizio Cucchi, Valerio Magrelli, chi è Marco Lodoli, Giorgio Caproni, chi è Amelia Rosselli, tutti poeti importanti. Si sono fermate e per loro la poesia è Pascoli, D’Annunzio, Leopardi. Non è vero, io non accetto queste cose. Io faccio un altro mestiere che è la musica, c’ho i calli sulle mani perché suono la chitarra, non starei qui se fossi un poeta: voi mi state intervistando perché sono un cantante, questo dovrebbe spazzare il terreno. Dopo di che io stesso non so dare una definizione di poesia, nessuno la sa dare. Perché una cosa è una poesia? Qual è l’anima della poesia? Non me lo chiedo, non lo so, non lo voglio sapere. Alla fine poi mi va bene tutto: se uno mi vuole chiamare poeta, mi chiamasse poeta; se uno mi vuol chiamare idraulico, mi può chiamare idraulico. Nessuna delle due cose mi offende: non la trovo esatta come definizione, ecco, tutto qua. Dylan poi di se stesso non so cosa pensi: sicuramente sa di avere una forte valenza letteraria, ma quella anch’io so di averla, però non è la stessa cosa che dirsi poeta. Dylan si è definito una volta un song and dance man, un ‘ballerino’, per dirti che evidentemente anche lui non vuol essere chiuso dentro una capsula. Non so se lui abbia mai detto qualcosa di tutti i tentativi che ci sono stati per dargli il Nobel per la letteratura, che poi non glielo danno mai. Forse sarebbe contento, anch’io sarei contento se mi dessero il Nobel per la letteratura. D’altra parte se lo ha preso Dario Fo, lo può prendere anche Bob Dylan, lo potrei prendere anch’io. Però la definizione di poeta mi suona sempre un po’ inutilmente laudatoria, nell’intenzione di chi me la porge, e scorretta dal punto di vista tecnico. Non credo neppure che i testi stiano in piedi da soli come lettura, né i miei, né quelli di Dylan, né quelli di nessun altro. Shakespeare sta in piedi da solo. Anzi, ti dirò, le cose che stanno in piedi da sole, guai a musicarle, guai. Ogni tanto qualcuno si mette a musicare qualcosa, Leopardi, Shakespeare, Dante, guai, per carità!
A.C.: Di Dante dicono che nelle campagne toscane lo cantavano in ottava rima…
Forse sentirlo cantare allora in ottava rima poteva avere un senso. Ma oggi, pensa se Riccardo Muti, o Giovanni Allevi, si mettessero a fare una registrazione di Dante. Sono due cose diverse, anche se hanno la stessa nobiltà culturale tutte e due. Poi, se tu mi dici che Fellini è poetico, nel senso in cui io sono poetico, allora sì. Perché la poeticità attiene a tante cose, anche alla pubblicità: fanno certi spot pubblicitari che sono poetici; avete visto quello di Bob Dylan con il computer?
R.B.: Prima di approfondire il lavoro del CD mi piacerebbe parlare della copertina…
Chiaramente non potevo metterci una foto mia, in un disco intitolato De Gregori canta Bob Dylan, dove i nomi sono due; né potevo metterci una foto di De Gregori vicina a quella di Dylan. Allora ho pensato a una copertina grafica, ho pensato di far scrivere soltanto De Gregori canta Bob Dylan, senza immagini, però volevo uno sfondo un po’ complesso. Ne ho parlato con la grafica, una ragazza di Milano che si chiama Flora Sala, dicendole che desideravo una cosa un po’ ‘pixellata’, oppure uno sfondo neutro ma un po’ sconvolto da qualche elemento che distorcesse la piattezza. E lei è andata alla Galleria del Duomo, dove c’era un’installazione che proiettava su dei grandi schermi gli affreschi che stanno in alto, e ha visto questa enorme cosa pixellata: l’ha fotografata per farmi vedere come poteva venire lo sfondo, l’immagine è piaciuta a entrambi e la copertina l’abbiamo fatta così. È stata quindi una casualità, dove alla fine questa immagine un po’ mitologica ricorda molto – ecco un ulteriore furto… – certe copertine di Dylan tipo quella di Tempest, nella quale c’era una specie di statua romana…
A.C.: Questa immagine ha qualcosa di inca, di azteco…
Sì, di africano, di egiziano… Insomma, me la sono trovata addosso e ho detto: perché no?
A.C.: Passando alla musica, come sono costruiti gli arrangiamenti del disco? Si sente un po’ di De Gregori Band, un po’ di Dylan, e il risultato complessivo parla di un’ulteriore maturazione.
Diciamo che il suono della mia band è già di partenza molto dylaniano. Sono anni che dico ai miei musicisti di ascoltare cosa fanno i musicisti di Dylan, li ho anche portati ai concerti di Dylan. Non mi vergogno a dirlo, abbiamo preso a modello quel suono, è naturale, è un artista che stimo. Poi, nel realizzare gli arrangiamenti, ci sono due tipi di scelte che abbiamo praticato: una è stata quella di attenerci in maniera molto fedele a ciò che aveva fatto Dylan su alcuni pezzi, come “Dignity”, “Series of Dreams” e “Not Dark Yet”, che sono tre pezzi dove negli originali c’è lo zampino di Daniel Lanois. Non ci sembrava giusto andare a cercare altre soluzioni, perché erano talmente belli dal mio punto di vista! Poi ho letto che Dylan, invece, aveva avuto dei problemi con Daniel Lanois a proposito degli arrangiamenti di questi pezzi. Ma io, francamente, questi problemi non li ho trovati. Così abbiamo cercato di sentire come si muovevano le chitarre, come si muoveva la ritmica; dove c’era un tamburello che faceva certe cose, abbiamo messo un tamburello che faceva la stessa cosa. Su altri pezzi invece questo non è stato possibile, né lo abbiamo desiderato. Prendi “Desolation Row” per esempio: la versione pubblicata su Highway 61 è una delle tante versioni che Dylan ha registrato di quel pezzo. E mi sembra di capire che Dylan lavorasse in questo modo: suonava il pezzo tre, quattro volte, fino a che non gliene piaceva una versione e la teneva. Ma non è che ci fossero degli arrangiamenti: a quel tempo lui aveva una band di musicisti amici, più alcuni turnisti presi lì dove registravano. Non avevano parti scritte e tenevano quello che veniva: quegli svisi di chitarra, erano stati suonati quella volta e poi non più. Quindi un arrangiamento così poco codificato, evidentemente, non poteva essere riprodotto dopo quarant’anni rifacendo le stesse cose, perché gli sarebbe mancata la spina dorsale, la parte d’improvvisazione che c’è. Così, sugli arrangiamenti dove c’era molta improvvisazione, noi ci siamo allontanati.
A.C.: Avete evocato alcuni riff rifacendoli in modo diverso…
Io in “Desolation Row” ho messo “Last Night I Had The Strangest Dream”, un canto radicale americano, un inno pacifista di quegli anni. Nella strofa finale, dove Dylan nella versione originale non canta ma fa un assolo di armonica, io non mi sono azzardato a rifare l’assolo di armonica come lo fa Dylan; l’ho fatto nella versione di De André, poi me ne sono anche pentito. E allora mi è venuto in mente di metterci questa melodia un po’ da Esercito della Salvezza, da marching band. Quindi anche lì, nei punti dove non era possibile ‘tradurre’ fedelmente l’arrangiamento – parliamo di traduzione anche riguardo agli arrangiamenti – me ne sono allontanato. Per esempio, in “Subterranean Homesick Blues”, l’arrangiamento della base è pressoché identico, perché era abbastanza facile rifarlo; mentre invece il canto va completamente da un’altra parte, quasi in un arrangiamento ‘rappato’, perché era impossibile fare l’originale.
A.C.: Il discorso che volevo tentare di fare a proposito degli arrangiamenti è più semplice farlo per il tuo canto. Se partiamo dai complimenti per la tua crescita vocale che Dalla ti ha fatto in occasione della vostra ultima tournée insieme, in questo disco c’è poi un tuo lasciarti andare a tratti ad accenti dylaniani…
La tentazione era forte…
A.C.: Certo, la tentazione era molto forte, e il risultato sembra essere stato, come si dice: uno più uno uguale tre! La somma dei due elementi ha prodotto un avanzamento, che è già presente negli arrangiamenti, ma nel canto è più evidente.
Lo sai, un disco è un gioco di specchi. In questo senso io sono sempre stato uno che ha avuto Dylan come forte riferimento, e questo è stato detto, contestato a volte, riconosciuto da me, sempre. Quindi io sono, non dico speculare a Dylan, ma comunque Dylan c’entra molto con tutto il lavoro che ho fatto fino ad ora. Il fatto che io adesso lo traduca, diventa una specie di cortocircuito strano: è pieno di cortocircuiti strani questo disco, a cominciare dal titolo Amore e Furto, che è a sua volta un furto di un disco in cui Dylan metteva i furti che aveva fatto lui. Per la voce succede la stessa cosa: si crea questo effetto strano di spiazzamento perché è De Gregori, poiché in realtà io canto come De Gregori, però qua sto cantando Dylan, ma forse ho sempre cantato un po’ come Dylan. Dylan l’ho preso come mio riferimento, così come Frank Sinatra è stato il riferimento per tanti cantanti americani: quanti Frank Sinatra, quanti Elvis, quanti Dylan ci stanno in America? Il disco è una serie continua di tranelli, di rimandi, anche nel canto, anche nella vocalità: è chiaro che poi io, cantando le melodie di Dylan, mi avvantaggio…

A.C.: Volevo concludere sullo specifico nostro della chitarra: cosa ti senti di dire dei chitarristi di De Gregori?
Li ho sempre guardati con invidia, e si potrebbe chiudere qua la storia dei miei chitarristi! A parte gli scherzi, ne ho avuti tanti. Magari quelli antichissimi lasciamoli stare, ma per esempio devo assolutamente fare un brindisi a Marco Manusso: a parte che è un bravo chitarrista, ma mi regalò anche un paio di riff su Titanic di cui gli devo essere molto grato. Poi Vincenzino Mancuso: l’ho rivisto adesso negli ultimi concerti che ho fatto a Palermo, mi è venuto a trovare. Ho avuto sempre bravi chitarristi. Adesso ci sono Paolo Giovenchi, Lucio Bardi e Alessandro Valle, che non è proprio un chitarrista ma un uomo che lavora con le corde, il mandolino, la pedal steel. Che ti devo dire, li ho sempre invidiati e li ho anche sempre violentati; e loro hanno accettato. Ogni tanto chiedo loro delle cose, che all’inizio non sanno nemmeno se io sia completamente scemo oppure no, poi riescono a farle e se le fanno anche piacere, magari alla fine gli piacciono anche. Quindi irrompo nella loro tecnica, nella loro sapienza, nel loro talento di chitarristi, con delle idee che sono poco ortodosse, con una visione della chitarra se vuoi rudimentale, ma questo crea molto movimento. E tutti sono sempre stati al gioco. Paolo ogni tanto mi dice addirittura che dovrei suonare di più la chitarra io, perché potenzialmente potrei essere – ma nella prossima vita, dico io – un bravo chitarrista…
A.C.: Probabilmente intende nel senso che dai una certa impronta, che puoi dare solamente tu…
Nei dischi io la suono molto poco la chitarra. In questo disco di Dylan per esempio non l’ho mai suonata, dal vivo la suono di più. E ogni tanto faccio delle cose che vedo che suscitano interesse da parte dei miei chitarristi; magari le faccio male, fuori tempo, però capisco che loro dicono: «Che cazzo stai facendo? Però è bello»… In quei momenti mi sento un chitarrista anch’io!
A.C.: Puoi parlarci delle tue chitarre, delle tue preferenze? Partirei da un racconto che mi ha fatto Luigi proprio l’ultima volta che ci siamo sentiti: mi ha raccontato che aveva una Gibson J-45 e che è riuscito a convincerti che suonasse meglio della tua Martin; così tu hai preso la sua Gibson e gli hai dato la tua Martin. E di fatto adesso suoni spesso le Gibson. Chi prevale nell’eterna competizione tra Gibson e Martin?
Mah, le Gibson sono più gestibili: quelle che uso io, che sono delle Gibson di buon livello ma non sono i modelli top, mi sembrano decisamente più gestibili quando suoni con la band. Invece le Martin, per quello che sento io, sui bassi hanno una profondità che è troppo ‘grossa’; per suonarle insieme al gruppo, devi equalizzarle, devi ‘chiuderle’…
A.C.: Hai avuto solo Martin dreadnought o anche di altri formati?
R.B.: Però quello che dice è vero: anche le OM suonano ‘profonde’, mentre le Gibson sono più equilibrate.
Se tu fai un concerto voce e chitarra, sicuramente le Martin ti danno più suggestione. Le Martin ce le ho sempre, però dal vivo non le uso più. Uso le Gibson, due Jumbo che alterno, intanto perché ci potrebbe passar sopra anche un autocarro, poi perché adesso mi ci trovo meglio anche come manico. Ma non mi chiedete troppe cose di competenza tecnica sulle chitarre…
A.C.: Comunque anche le Gibson sono molto dylaniane, come si può vedere dalla copertina di Nashville Skyline…
Sì, ma in questo aspetto non sto imitando Dylan. È stato Paolo che mi ha portato nel territorio Gibson. Ma per concludere, se avete ancora cinque minuti, vi faccio sentire alcune cose di Dylan. Nel 2003 ha pubblicato questo disco, Masked and Anonymous, nel quale ha inserito diverse cover di sue canzoni interpretate tra gli altri dagli Articolo 31, i Grateful Dead, Los Lobos, Jerry Garcia, più alcune cose cantate da lui stesso. Vi faccio sentire per esempio un’improbabile versione di “My Back Pages” realizzata da un gruppo giapponese, The Magokoro Brothers. Poi vi faccio sentire questa cosa straordinaria che è l’inno sudista “Dixie”, cantato da Dylan, che lui fa diventare una canzone tragica, drammatica, dove si sente tutto il dolore di una guerra civile. L’uomo è imprevedibile, la gente cerca di capire chi è…
Reno Brandoni e Andrea Carpi




